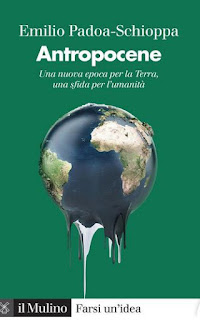Secondo Tolstoj si usa la parola vita per indicare il fenomeno in generale per esempio nella cellula, ma in realtà la vita è "la coscienza della sofferenza e dei godimenti e la aspirazione al bene" (50)
So di essere vivo perché ho consapevolezza di me come corpo unico e indivisibile. Le scienze esaminando solo un aspetto della vita hanno la pretesa di definire la vita nel suo insieme ma la vita non può essere vista simultaneamente da tutti i lati.
"non sarà ciò che chiameremo scienza a definire la vita, ma il nostro concetto di vita definirà ciò che bisogna riconoscere come scienza." (58)
Bisogna allora stabilire innanzitutto cos'è la vita: per ogni uomo vivere significa perseguire il bene, il suo personale inizialmente. Ma poi scopre che il proprio bene dipende da quello degli altri.
La vita persegue il bene, il bene reale indiscutibile invece di quello falso e impossibile dell'individuo. Ma vi sono:
-gli scribi, coloro che pensano che la vita dell'uomo è solo la sua esistenza animale dalla nascita alla morte e la falsa scienza, il materialismo, per il quale la vita dell'uomo e degli altri animali si riduce alla lotta per l’esistenza.
-i farisei, cioè i falsi maestri, i preti: la vita può essere corretta dalla fede in un'altra vita acquistabile con l'osservanza di riti esteriori.
Scribi e Farisei nascondono l'eterna dottrina di religioni, filosofia, ecc.
Nel suo agire quotidiano l'uomo si fa guidare dalla consuetudine sociale cioè l'etichetta, le vacanze, i doveri sociali, eccetera che non hanno alcun senso ma sembrano averlo. L'uomo vive così nella convinzione che la vita sia la vita animale e confonde la vita con la propria coscienza, crede di aver vissuto. La vita inizia soltanto con il risveglio della coscienza razionale che rivela la vita degli altri. La vera vita è presente nell'uomo come la pianta è contenuta nel seme, e esce fuori quando ci rendiamo conto che la vita nella individualità è impossibile. Ecco allora il risveglio della coscienza razionale cioè la nascita di un nuovo essere: la ragione è il principio indefinibile, è la legge che regola la vita dell'uomo e di tutti i fenomeni. Sottomissione del nostro corpo animale alla ragione al fine di conseguire il bene.
La legge della ragione è la sola conoscenza vera, sapere il funzionamento della vita animale, vegetale e del mondo materiale non ci dice nulla della vera vita dell'uomo. La falsa conoscenza avviene quando l'uomo non sa ciò che invece dovrebbe sapere, la coscienza razionale, e crede di sapere ciò che non sa, la vera vita.
Conosciamo pienamente solo la nostra aspirazione al bene e la ragione che ce la indica. La vera vita umana avviene fuori del tempo e dello spazio, è "aspirazione al bene conseguibile attraverso la sottomissione dell'individualità alla legge della ragione." (123)
L'individualità animale non è vita vera ed è destinata a consumarsi nella morte, vita vera è l'aspirazione al bene che non si consuma, ma l'aspirazione al bene deve essere aspirazione al bene degli altri prima di tutto, che cancella l'illusoria ricerca del piacere individuale e annulla l'altra causa di infelicità: la paura della morte.
Allora la prima legge della vita non è la lotta per l'esistenza ma il mettersi al servizio l’uno dell'altro. L'uomo percepisce i suoi innumerevoli bisogni individuali, l'uomo razionale non può rinunciare alla propria individualità animale con tutti i bisogni ma non deve pensare che sia la vera vita. La vera attività ragionevole dell'uomo è l'amore.
Amare è desiderare di fare il bene. Amore è attività mirante al bene degli altri. La base dell'amore è la rinuncia al bene personale e quindi la benevolenza verso tutti gli altri che ne deriva. La vera vita allora è "l'invisibile ma indubbia sottomissione del proprio io animale alla legge della ragione in ogni attimo del presente, sottomissione che libera la benevolenza verso tutti, insita nell'uomo, e l'attività d'amore che ne scaturisce." (176)
La morte esiste solo per quelli che credono che la vera vita sia l'individualità animale. Il carattere di una persona è ciò che egli ama o non ama (quindi che resta inspiegabile) ed è ciò che unifica l'io mutevole dell'uomo. Il carattere costituisce il rapporto con il mondo, cioè il vero io. La morte non annienta il vero io che continua a esistere negli altri.
La vera vita è solo una parte della vita intera che si collega a ciò che viene prima della nascita e dopo la morte.
La vita è soggetta a una imprevedibile serie di sofferenze.